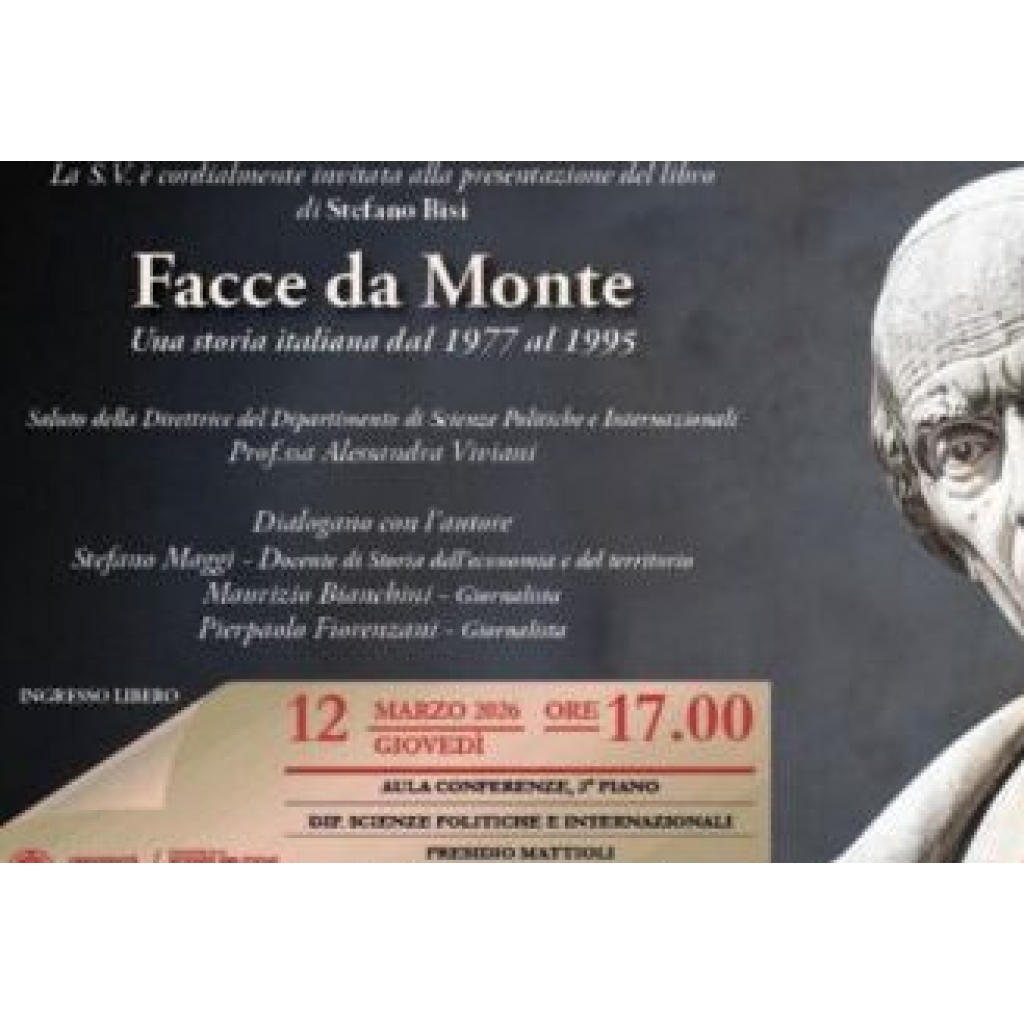Crans-Montana, un dramma da elaborare nella maniera giusta

di Paolo Benini.
Crans-Montana è uno di quei drammi che rischiano di restare solo tragedie, oppure, se letti con un minimo di freddezza e di onestà intellettuale, possono diventare episodi dolorosi ma istruttivi. In questi giorni, dopo la morte di tanti ragazzi, tante persone giovani, si è aperto un dibattito immediato e comprensibile. Quando accade qualcosa di così violento, il bisogno di spiegazioni è urgente. Ed è proprio in questa urgenza che spesso e purtroppo si infilano scorciatoie interpretative pericolose. L’attenzione si è concentrata quasi subito su due bersagli evidenti: il telefonino e il gestore del locale. È una giusta necessaria lettura che tuttavia e’ parziale. Non perché questi elementi siano irrilevanti, né perché le responsabilità, anche legali, non debbano essere accertate. Quelle vanno accertate sempre. Ma cercare un colpevole in senso giuridico non esaurisce l’analisi del fenomeno, non lo spiega e soprattutto non aiuta a prevenirlo. Confondere la ricerca di una responsabilità legale con la comprensione di un processo psicologico è una scorciatoia che rassicura, ma non risolve.
Il telefonino, in particolare, è stato trattato, come spesso accade, come se fosse l’elemento disturbante per eccellenza, quasi un agente esterno capace di sabotare da solo il comportamento umano. In realtà è uno strumento tecnologico che oggi si trova nelle mani dei giovani, come altri strumenti si sono trovati nelle mani di giovani in altre epoche. È più pervasivo, più rapido, più immersivo, certo. Ma il punto non è l’oggetto. Il punto è chi lo usa e con quali risorse interne. Un ragazzo di quindici o sedici anni non ha ancora completato lo sviluppo della corteccia prefrontale, l’area che regola la pianificazione, la valutazione del rischio, l’inibizione delle risposte non funzionali. Le funzioni esecutive non sono ancora pienamente stabilizzate, mentre l’attivazione emotiva è intensa e spesso disorganizzata. Questo non è un giudizio morale, è un dato neuropsicologico, e’ una condizione fisiologica.
Arriviamo così al nodo più delicato, quello che spesso viene semplificato in modo improprio. Non è corretto dire che questi ragazzi non sapessero cosa fare. È ragionevole pensare che, a livello cognitivo, a freddo, sapessero che davanti a un incendio si scappa. È una regola semplice, culturalmente condivisa. Il problema non è l’assenza della conoscenza, ma l’accesso a quella conoscenza nel momento critico. Non siamo davanti a un choking under pressure in senso stretto, quello classico che riguarda competenze pienamente automatizzate che collassano sotto pressione. Qui la competenza esiste, è ben definita, ma non è ancora diventata un automatismo stabile. Ed è proprio per questo che la situazione è comunque molto simile a un “choking under pressure”: la risposta corretta è immagazzinata, ma sotto stress non viene reclutata. Quando lo stress è acuto, l’evento è improvviso, il gruppo è intorno, i segnali sono ambigui, il sistema va in sovraccarico. L’attenzione si frammenta, il comportamento rallenta, si osserva, si resta agganciati agli altri, si compiono azioni inefficaci. Non perché si sia incapaci o incoscienti, ma perché la risposta adattiva non scatta automaticamente.
I lavori di Sian Beilock sul comportamento sotto pressione aiutano a capire bene questo punto: quando il controllo cognitivo è fragile, l’organismo tende a cercare riduzioni immediate dell’attivazione emotiva, non soluzioni ottimali sul piano adattivo. In questo quadro il telefono può diventare un elemento di mediazione. Sposta il soggetto dalla scena alla rappresentazione della scena, da attore a osservatore. I lavori di James Gross, a Stanford, sulla regolazione emotiva lo spiegano bene: cambiare prospettiva riduce l’impatto emotivo immediato, ma può anche ritardare l’azione quando le funzioni di controllo non sono ancora mature. Il telefono non crea il problema, si inserisce in una vulnerabilità già presente. E infatti non tutti filmavano. Alcuni restavano immobili, altri guardavano, altri cercavano di spegnere il fuoco in modi ridicoli, senza avere competenze né mezzi, altri restavano agganciati al gruppo. Qui entrano in gioco dinamiche note come l’omologazione, il freezing e il bystander effect: quando molti osservano, ciascuno tende ad attendere che sia qualcun altro ad agire, e in adolescenza questa tendenza è particolarmente marcata. Studi sul decision making in condizioni di stress mostrano chiaramente che senza automatismi interiorizzati la risposta tende a essere lenta, disorganizzata e fortemente dipendente dal comportamento altrui. Attribuire tutto al gestore del locale produce una distorsione simile. Le norme di sicurezza sono fondamentali e riducono il rischio in termini probabilistici, ma non lo annullano. Anche in un contesto a norma può verificarsi un evento critico.
Ed è in quel momento che entrano in gioco le risposte umane. È un po’ come accade nella scuola: quando qualcosa non funziona, la colpa viene spesso attribuita interamente all’insegnante. È rassicurante, ma riduttivo. L’errore opposto, però, è dire che allora non è responsabilità di nessuno. Qui vale lo stesso principio. Le responsabilità giuridiche vanno accertate, ma non basta. Accanto al piano giuridico esiste un piano psicologico ed educativo che non può essere ignorato. I ragazzi, con il loro livello di sviluppo. Gli adulti, con la funzione di guida. Chi organizza i contesti, con le responsabilità strutturali. Le istituzioni, con il compito di controllare. E resta una domanda che spesso viene evitata perché scomoda: stiamo forse sopravvalutando la capacità di questi ragazzi di autoregolarsi, tanto più quando vengono inseriti in contesti che presentano un certo coefficiente di rischio? Stiamo confondendo la loro autonomia cui non sono preparati con emancipazione? Non si tratta di colpevolizzare nessuno, men che meno i genitori. Ma pensare che soggetti ancora in crescita possano gestire in autonomia situazioni emotivamente cariche, affollate, rumorose e potenzialmente pericolose significa probabilmente chiedere loro più di quanto le loro strutture cognitive ed emotive siano oggi in grado di offrire. Un ragazzo ha raccontato di essere scappato subito perché cresciuto con una regola semplice: davanti al pericolo si va via. Quel comportamento non nasce nell’emergenza. È un automatismo costruito prima. Ed è lì che si gioca la partita vera. Preparare non significa terrorizzare, significa trasformare conoscenze corrette in risposte automatiche. E, in certi casi, bisogna dirlo, anche limitare, proibire l’accesso al rischio potenziale quando sappiamo che quelle competenze non sono ancora disponibili o una situazione non ci convince. Per carita’ il destino esiste, la sfortuna e’ in agguato ms insomma cerchiamo di non aiutarla. Se Crans-Montana verrà letto come si vede adesso , non ci insegnerà nulla. Se invece lo leggiamo con occhi neutrali,senza scorciatoie, può rappresentare un cambio di paradigma, perché ci costringe a guardare non solo cosa è successo, ma come funzionano davvero le persone quando la pressione arriva all’improvviso e a chiederci, senza accuse ma senza ipocrisie: chi deve occuparsi di prepararle prima? Di metterci quelle capacita’ di valutare che loro ancora non hanno?